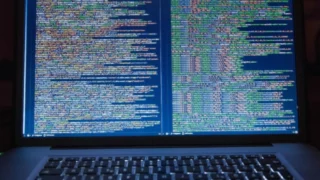A seconda dell’età del soggetto al quale rivolgete la domanda «conosci il nome di un robot umanoide?» vi sentirete rispondere Asimo (costruito dalla Honda) dai più anziani oppure Nao (opera della Aldebaran Robotics) da ragazzi, ricercatori e… medici.
Fin dalla sua prima incarnazione – pardon, release – la creazione della Aldebaran ha catturato l’attenzione del mondo dell’istruzione (secondaria e universitaria) e la fantasia dei non addetti ai lavori. I primi hanno finalmente avuto a disposizione uno strumento (relativamente) economico per sperimentare la programmazione orientata alla gestione di una macchina umanoide, e i secondi sono messi in condizione di sperimentare – adesso – un futuro molto prossimo, nel quale i robot saranno una presenza diffusa nella nostra vita quotidiana.
Certo, sul mercato non mancano esempi di robot che parlano, si muovono e compiono operazioni complesse con apparente naturalezza, ma si tratta invariabilmente di prototipi, fenomeni da baraccone o esemplari unici, realizzati per scopi specifici.
Non è così per le creazioni della Aldebaran che, ed è questa la loro caratteristica, sono evidentemente frutto di un preciso progetto culturale ancora prima che industriale: aiutare a sviluppare nelle persone una corretta consapevolezza sul concetto di robot, offrendo la possibilità non solo di usarli ma anche di capire come funzionano grazie a Choreographe, l’ambiente di sviluppo visuale per la programmazione di queste macchine, scaricabile e utilizzabile gratuitamente per 90 giorni.
Il robot Pepper, in grado di riconoscere le emozioni dalle espressioni, mentre accoglie un giovane visitatore.
L’esperienza insegna che le macchine suscitano reazioni irrazionali e violente, invariabilmente legate alla paura di perdere soldi, lavoro e – in definitiva – potere, e che, tuttavia, alla lunga le persone accettano l’innovazione fino a darla per scontata, non riconoscendola più per tale.
È accaduto per la tecnologia del vapore, con quella dell’autotrasporto, con l’informatica e accadrà , domani, con la robotica. In questo senso, dunque, la strategia della Aldebaran è molto intelligente perché cerca di disinnescare il conflitto prima che esploda. E’ un approccio inusuale, totalmente diverso da quello di altri giganti dell’ICT che, invece, sotto la patina ipocrita della “interattività ” riducono gli utenti come gli umani nel mondo di Matrix: combustibile rinchiuso in bozzoli, la cui unica funzione è produrre energia per alimentare il sistema
È per questo motivo che ho deciso di approfondire il tema, facendo un cosa non più molto in voga nell’era del giornalismo online: andare di persona sul posto per farmi un’idea “di prima mano”. E dunque, caricate armi e bagagli, sono partito alla volta di Parigi, dove, in una zona periferica lontana dalle rotte turistiche, si trova l’Atélier Aldebaran.
Lo spazio riservato alle visite si trova al piano terra, entrando, sulla sinistra, come suggerisce immediatamente l’addetto alla reception dicendomi: vous-etes ici pour le robot? (siete qui per vedere i robot?). È un open space sobrio e accogliente, il pavimento di parquet e i muri tappezzati di monitor, un po’ laboratorio e un po’ aula, dove Nao e Pepper (una sorta di robot-maggiordomo che “legge” gli stati d’animo delle persone), sono pronti a interagire con i visitatori che possono anche partecipare a corsi diversificati per fascia di età .
Mentre Aurore Chiquot, responsabile dell’ufficio stampa, mi spiega la filosofia che sta alla base del progetto Aldebaran, ho potuto osservare il modo in cui due bambini di otto e dieci anni che non parlavano francese si sono rapportati con i robot disponibili per il pubblico. L’esperienza è stata molto istruttiva perché è stato palese che, pur riconoscendo evidentemente che si trattava di macchine, i bambini li hanno trattati da loro “pari” partecipando ad alcuni giochi matematici coordinati interamente dai robot e ballando insieme a loro. Questa reazione, mi è stato spiegato, è molto comune fra i più piccoli, tanto che alcuni medici hanno cominciato ad usare Nao per comunicare con bambini autistici, ottenendo promettenti risultati. È ancora troppo presto per formulare conclusioni definitive, ma da quanto risulta, la forma antropomorfa di Nao e la sua capacità di interazione sembrano ben accolte dai bambini affetti da questa patologia.
Parlare – specie in questi tempi – di “integrazione” in rapporto a delle macchine può sembrare un fuor d’opera, ma in realtà non è così. Anzi, è vero il contrario: quanto più le macchine avranno forme e funzioni antropomorfe, tanto più dovremo essere ben consapevoli di cosa possono fare per noi e di come possiamo/dobbiamo usarle. Un risultato del genere, però, si può ottenere soltanto studiandole da prima possibile, in modo da rendere la loro presenza un utile aiuto alla nostra vita quotidiana invece di un banale copione da film di fantascienza di quarta serie.
Chapeau, dunque, alla Aldebaran Robotics per avere capito – prima e meglio di altri – che la tecnologia senza cultura produce soltanto oggetti privi di anima.