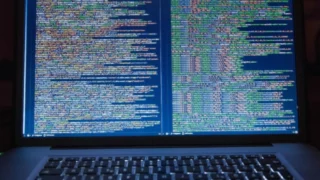Una data, 18 marzo 2018, purtroppo da ricordare. Nella cittadina di Tempe, in Arizona, si è verificato il primo incidente mortale tra un pedone e una self driving car. La vettura coinvolta è stata una delle Volvo XC90 di Uber, appositamente modificate per la guida autonoma di livello 4. Un incidente che ha sollevato immediatamente (e giustamente) il problema della sicurezza e dell’affidabilità delle auto a guida autonoma. Preoccupazioni sacrosante, ma che rischiano di scatenare un eccessivo allarmismo. Purtroppo l’opinione pubblica tende a considerare le auto a guida autonoma tutte sullo stesso piano, ma è un settore in cui molti colossi (automobilistici e non) sono scesi in strada, con progetti – e livelli di sperimentazione – ben diversi.
È evidente che, nel caso specifico, qualcosa non ha funzionato, ma è altrettanto evidente il fatto che Uber stesse cercando a tutti i costi di bruciare le tappe. Di fronte a una vita umana, fare parlare i numeri può sembrare cinico, ma in questo caso è necessario. La più famosa tra le self driving car è senza dubbio quella di Google (anche se sarebbe ormai più corretto parlare della sua società spin-off, la Waymo). Ebbene, il loro progetto è operativo su strada dal 2009 e a febbraio ha superato il traguardo dei 5 milioni di miglia (oltre 8 milioni di km). Non solo tanti chilometri reali, ma anche tantissimi chilometri “virtuali”: nel solo 2017 le Google car hanno “percorso” sul simulatore oltre 4,3 miliardi di chilometri.
E Uber? È entrata in questo settore solo nel 2015, con il primo prototipo su strada pronto a settembre 2016. Secondo gli ultimi dati disponibili, a fine 2017 le Uber car avevano percorso complessivamente 2 milioni di miglia (3,2 milioni di km), ma era evidente come il progetto avesse ricevuto un’accelerazione brusca, con vere e proprie marce forzate che, a suon di 84 mila miglia alla settimana, gli avevano fatto “macinare” un milione di miglia in appena 100 giorni.
Uber tentava di colmare la distanza da Waymo solo a suon di chilometri, ma la sicurezza era in secondo piano. Un dato, su tutti, è la frequenza di “sganciamento” ovvero ogni quanti km il co-pilota umano deve “sostituirsi” al computer, bypassare il sistema e intervenire in una situazione potenzialmente critica. Oggi le Google car richiedono in media l’intervento dell’uomo una volta ogni 5.600 miglia, mentre quelle di Uber, secondo le stime più rosee, una volta ogni 13 miglia. In pratica, sbagliano 400 volte di più. Ma perché allora tutta questa fretta? In gioco ci sarebbe la stessa sopravvivenza di Uber. In un’intervista del 2016 a Business Insider l’ex CEO, Travis Kalanick aveva giustificato gli sforzi affermando “Se non arriviamo tra i primi, allora la persona o la società che arriverà prima proporrà un network di ride-sharing molto più economico o di qualità molto maggiore rispetto a Uber, e allora non esisteremo più”.
Lo stop della sperimentazione di Uber non solo è necessario per analizzare, nello specifico, cosa non ha funzionato questa volta, ma dovrebbe servire a capire che gli interessi economici non rendono le nostre strade e le nostre città un labirinto per cavie. E se pensate che sia un problema solo americano, sappiate che nei prossimi anni ci riguarderà da vicino: il 6 marzo, infatti, il Ministro delle Infrastrutture Delrio con il decreto “Smart Road” ha dato il via libera anche in Italia alla sperimentazione delle tecnologie di guida autonoma. Forse lo dimentichiamo, ma, come diceva Umberto Eco “Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi, è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti”.